Le festività nell'antica Roma
Nella Roma antica feste e cerimonie sacre erano due elementi indissolubili. A causa della connessione tra religione e res publica, non esistevano feste pubbliche che non avessero una connotazione sacra e durante le quali non si svolgessero quindi anche riti, di qualsiasi tipo fossero. Le feste ufficiali, feriae publicae, erano tutte registrate sul calendario, posto sotto l’autorità dei pontefici. Se ne contavano 45 maggiori a data fissa, altre la cui data era comunicata ogni anno, e infine altre ancora straordinarie, indette in occasione di avvenimenti speciali. Delle 45 maggiori, che cadevano sempre nello stesso giorno, molte erano ricorrenze di dediche di templi ed erano quindi indicate sul calendario con il nome dell’edificio, altre erano connesse con cerimonie di antichissima origine, poiché il calendario, per quanto aggiornato e trasformato nei secoli, mantenne sempre il nucleo primitivo incentrato sulla vita e sui cicli di una società agricola, pastorale e guerriera.
Le festività legate alla guerra erano concentrate a marzo e ad ottobre, perché nell’età più antica le azioni belliche erano condizionate dalla situazione metereologica e limitate ai mesi primaverili ed estivi. Originariamente quindi, l’anno iniziava a marzo, quando riprendevano le guerre: il primo, il nove e il ventitré marzo i Salii, i sacerdoti di Marte, svolgevano la loro famosa processione con gli scudi sacri. Ad ottobre, quando si dava termine alle campagne di guerra, si celebravano feste connesse a Marte ed ai cavalli. In particolare il 19 ottobre si compiva la purificazione delle armi dal sangue nemico ed i Salii riponevano i loro scudi.
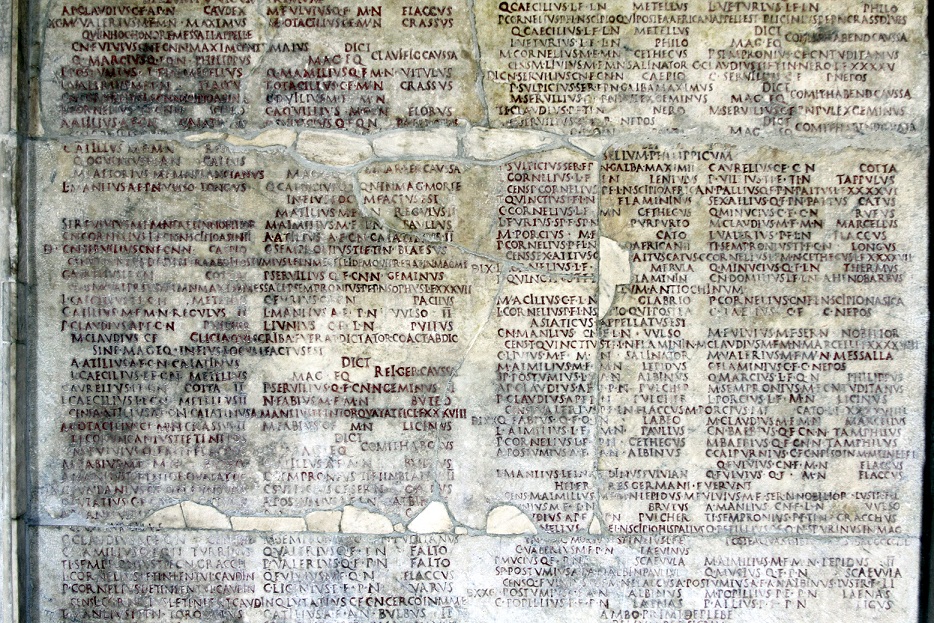
Molte celebrazioni erano connesse con il ciclo agrario. Ad aprile si susseguivano ben quattro feste di questo tipo, i Fordicidia in onore di Tellus, i Cerialia per Cerere, dea del grano e della fertilità, i Vinalia nel giorno in cui veniva spillato il vino nuovo e infine i Robigalia, in onore di una divinità che doveva allontanare dai cereali una malattia chiamata ruggine. A maggio seguivano i Floralia, poi ad agosto le feste relative al raccolto, i Consualia e gli Opiconsivia, ripetute a dicembre per la semina. La più importante del ciclo erano i Saturnalia, che celebravano la chiusura delle attività agricole, in onore del dio che si credeva avesse regnato nell’età dell’oro, quando non era necessario lavorare. Il 17 dicembre, che era il giorno di celebrazione dei riti sacri, coincideva con il dies natalis del tempio di Saturno, e per quasi una settimana, fino al 23 dicembre, non si lavorava e si viveva in un clima di licenziosità e di trasgressione, ben più marcato dello spirito di baldoria del Capodanno e del Carnevale moderni.
Febbraio invece, a chiusura dell’originario anno liturgico, era il mese dei defunti e delle lustrazioni. L’idea della grave contaminazione prodotta dal contatto con la morte è all’origine della stretta connessione tra riti funerari e di purificazione. A febbraio quindi, si celebravano i Lupercalia per la purificazione e tre festività in onore dei defunti, i Parentalia, i Ferialia e i Caristia. Ai morti erano dedicati anche i Lemuria a maggio. Sempre connessa ai defunti (ma originalmente doveva essere legata al ciclo agrario) anche la cerimonia del Mundus, che si ripeteva tre volte all’anno, il 24 agosto, il 5 ottobre e l’8 novembre. Il Mundus era una fossa circolare nel Foro Romano, che in quei giorni veniva aperta, mettendo così in comunicazione il mondo dei vivi ed il mondo dei morti. I defunti uscivano dagli inferi e tornavano a vagare nella città e, a causa della contaminazione portata dalla morte, quasi tutte le attività erano interdette (matrimoni, battaglie, comizi ecc.).
(da: ROMA ARCHEOLOGICA, Elio de Rosa Editore, itinerario n. 20, p. 27).